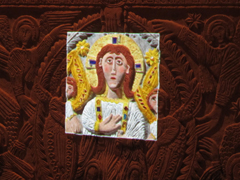CIVIDALE DEL FRIULI
La presenza umana nella zona dove oggi sorge Cividale risale a epoche piuttosto antiche, come attestato dalle stazioni preistoriche del Paleolitico e del Neolitico trovate appena fuori della città. La strategica posizione di questo primitivo insediamento indusse i Romani a stabilirvisi, fondando forse alla metà del II secolo a.C. un castrum, di ovvia natura militare. Nel 568 giunsero dalla Pannonia i Longobardi, di origine scandinava, il cui re Alboino elesse subito la romana Forum Iulii a capitale del primo ducato longobardo in Italia e ponendovi duca il proprio nipote Gisulfo. Ribattezzata la propria capitale Civitas Austriae, ossia "Città dell'Austria" (da cui il nome moderno), i longobardi vi eressero edifici imponenti e prestigiosi e nei dintorni fondarono strutture fortificate assegnate alle fare, ossia le stirpi nobili di quel popolo germanico. Alla dominazione longobarda sono legati i principali edifici e luoghi di maggior interesse artistico della città. Tra questi la galleria propone il tempietto longobardo (foto 1-8) e il museo cristiano (foto 9-16). Il tempietto, noto come oratorio di Santa Maria in Valle, collocato all'interno del monastero delle Orsoline, è la più importante e meglio conservata testimonianza architettonica dell'epoca longobarda ed è particolarmente rilevante perché segna la convivenza di motivi prettamente longobardi con una ripresa dei modelli classici, creando una sorta di continuità aulica ininterrotta tra l'arte romana, l'arte longobarda e l'arte carolingia e ottoniana. La parte più interessante è il fregio al livello superiore, liberamente sovrapposto agli elementi architettonici dell'edificio come le finestre. Qui si trovano sei figure a rilievo di Sante (foto 5,6), in stucco, eccezionalmente ben conservate: le loro monumentali figure sono da collegare ai modelli classici, riletti secondo la cultura longobarda. I panneggi delle vesti riccamente decorate hanno un andamento accentuatamente rettilineo, che ricorda i modelli bizantini, dai quali però le Sante si distaccano per il maggior senso del volume e per il verticalismo, ulteriormente marcato dalla lunghezza delle pieghe delle tuniche. Il Museo diocesano cristiano e del tesoro del duomo di Cividale, allestito in alcuni locali adiacenti al duomo di Santa Maria Assunta, fu inaugurato nel 1946 per conservare le testimonianze storico-artistiche più rappresentative della scultura altomedievale, soprattutto di epoca longobarda. Tra queste spiccano il Battistero ottagonale di Callisto dell'VIII secolo (foto 15,16) e l'Altare del duca Ratchis (foto 9-13), costruita in pietra carsica e datato tra gli anni 737 e 744. Composto da quattro lastre di marmo di Aurisina, presenta alla sommità un'epigrafe latina e sui quattro lati vari soggetti religiosi: la Visita di Maria Vergine alla cugina Elisabetta, detta anche semplicemente Visitazione; Cristo in maestà entro una mandorla sorretta da quattro angeli; l'Adorazione dei Magi. In foto anche come doveva apparire coi colori originali. Coerentemente a uno stile fortemente astrattizzante di matrice tardo antica, distante dalla resa naturalistica dei soggetti, le figure umane presentano alcune deformazioni, quali quelle delle grandi mani degli angeli che sorreggono la mandorla. I volti sono caratterizzati dall'assottigliarsi del mento (volti a "pera rovesciata"). L'antinaturalismo formale e il forte rimbalzo cromatico che le superfici avevano un tempo sottolineano con forza il valore sacro e simbolico dell'opera. Si può notare inoltre come permanga una simbolica gerarchia dimensionale dei personaggi per cui hanno grandezza maggiore i personaggi di maggior rilievo quali Maria rispetto alla cugina Elisabetta e Gesù rispetto agli angeli. A Cividale merita una visita anche il Duomo di Santa Maria Assunta che custodice diversi tesori tra i quali va ricordata soprattutto la Pala di Pellegrino II, uno dei più importanti capolavori medioevali dell'oreficeria italiana. La Pala (foto 18), collocata sull'altare maggiore, consta di centoventitré lastre d'argento dorato sbalzato.
GALLERIA FOTOGRAFICa