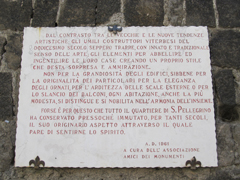Viterbo
Nel territorio di Viterbo vi sono tracce di insediamenti neolitici ed eneolitici, nell'ambito della cultura di Rinaldone. Sono state rinvenute poche presenze etrusche, specie nel sottosuolo, ma probabilmente in questo periodo l'insediamento sul colle del Duomo non raggiungeva lo stato di vicus ed era un avamposto della lucumonia di Tarquinia. Dopo la conquista romana vi fu costituito, con ogni probabilità, un insediamento militare, chiamato Castrum Herculis per la presenza nella zona di un tempio che si riteneva dedicato all'eroe mitologico, da cui deriva il leone simbolo di Viterbo. Nei pressi passava la via Cassia, che aveva una mansio ad Aquae Passaris, nell'area termale a occidente rispetto all'attuale Viterbo, mentre solo nel medioevo, con la sua ascesa politica, la strada passerà dentro la città. Notizie più certe si hanno nell'Alto Medioevo con un castrum, cioè una fortificazione longobarda posta al confine tra i possedimenti nella Tuscia e il ducato bizantino di Roma. Un documento papale dell'852 riconosce il Castrum Viterbii come parte delle Terre di San Pietro, mentre Ottone I annovera il castello tra i possedimenti della Chiesa. Nell'XI secolo l'incremento demografico contribuì alla nascita di nuclei abitativi fuori dal castrum, e, attorno al 1090, a un primo tratto di mura; nel 1099 la scelta dei primi consoli sancì il passaggio a istituzioni comunali. È il XII secolo il periodo in cui Viterbo, libero comune, si assicurò il possesso di numerosi castelli: in tal senso la protezione di Federico I Barbarossa (presente nella città nel 1162), e il suo riconoscimento del comune viterbese, conferì legittimità alla sua politica di espansione. All'inizio del XIII secolo la città fu finalmente inserita nell'orbita papale ed iniziò in tal modo un periodo di grande splendore. A partire dal 13 secolo infatti i pontefici scelsero Viterbo come sede papale. Seguono decenni di splendore della città, fino all'esilio avignonese dei papi, che determinò in seguito la decadenza di Viterbo e al riaprirsi delle lotte interne. Diversi sono i monumenti e i luoghi d'interesse delal città, cinta da mura quasi perfettamente integre. La Cattedrale di San Lorenzo (Duomo, foto 8-14), fu eretta in stile romanico nel corso del XII secolo, sul terreno dove era situata una piccola chiesa dell'VIII secolo dedicata appunto a San Lorenzo, a sua volta edificata sulle rovine di un tempio pagano dedicato ad Ercole, ma la sua facciata risale al 1570, quando fu rifatta in stile rinascimentale su disposizione del vescovo Giovanni Francesco Gambara. Poco distante si trova il Palazzo dei Papi (foto 15-20), costruito fra il 1255 e il 1266 sul colle di San Lorenzo per ospitare e proteggere i pontefici durante il loro soggiorno a Viterbo, con la celebre loggia formata in un solo lato da sette archi sorretti da esili colonnine binate che si intrecciano formando una elegante trabeazione. Dalla loggia si entra nella grande Sala del Conclave, teatro della famosa elezione di papa Gregorio X. Il quartiere di San Pellegrino (foto 21-31) è un quartiere del centro storico della città, situato sul percorso della via Francigena. La zona cittadina aveva caratteristiche residenziali e conserva torri e palazzi duecenteschi, spesso dotati di profferlo, che mantengono il loro aspetto medievale. Alcuni edifici sono andati distrutti durante le lotte per il potere tra le famiglie viterbesi, tra cui il palazzo Gatti, di cui rimane solo una piccola porzione in via Cardinal La Fontaine, mentre il palazzo degli Alessandri venne salvato soltanto grazie all'intervento di papa Innocenzo IV. Questo palazzo presenta la particolarità di avere un profferlo interno, cioè all'interno del perimetro dell'edificio e con un parapetto all'altezza dell'entrata, visibile dalla piazza. Tra le tante belle piazze cittadine la galleria propone delel foto di piazza del Gesù (foto 2,3) e piazza Plebiscito (foto 5,6).
GALLERIA FOTOGRAFICa